Ogni sistema energetico porta con sé un'idea di mondo
di Caterina Orsenigo
Nel funzionamento e nell’organizzazione di una rete elettrica c’è molto del funzionamento e dell’organizzazione del relativo sistema politico. In questo momento, come su molti altri fronti anche in tema di energia ci troviamo in una fase di passaggio. Le fasi di passaggio da un lato spaventano e ci calano nell’incertezza. Dall’altro sono le congiunture della Storia più interessanti, quelle in cui possiamo scegliere che tipo di mondo vogliamo. Dobbiamo cambiare sistema energetico, è un bivio e un’occasione ancor più importante di quanto potremmo pensare.
Prima di riflettere su dove possiamo andare, guardiamo però da dove veniamo.
La rete elettrica nazionale italiana nacque negli anni Sessanta. Era fatta di grandi centrali termoelettriche e idroelettriche che alimentavano tutte le reti. Venne costruita in modo da fornire energia a cascata, dall’alto in basso, diramandosi come un fiume o una rete stradale. Dalle centrali partivano i grossi fili che subito raggiungevano le cabine primarie, dove l’alta tensione si trasformava in media tensione. Da queste cabine primarie partivano i fili della media tensione: autostrade dell’energia che raggiungevano da una parte le grandi imprese e dall’altra le cabine secondarie. Da queste uscivano i fili più sottili della bassa tensione, come strade di città o di paese, che raggiungono tutto il territorio e alimentano case, scuole, ospedali. Trentasei milioni di utenti attingono da questi fili sottili. Mentre circa 100mila utenti, tra medie e grandi imprese, attingono direttamente ai fili della media tensione. Una sorta di sistema venoso in cui tutto parte dal cuore, o da cinque o sei cuori (aziende in parte statali, almeno all’inizio, poi sempre più private), che si spartiscono il mercato, irrorano sangue in tutto il Paese e decidono quanto deve costare il loro servizio.
Dagli anni Sessanta funziona in questo modo ed è ancora così, ma l’arrivo delle rinnovabili cambia le carte in tavola. Soprattutto se si parla di fotovoltaico: da un giorno all’altro, ogni cittadino può mettere un pannello sul tetto di casa o addirittura sul balcone. Ognuno di noi può produrre energia. L’aspetto più interessante però è che tutta l’energia in eccesso finisce in rete e diventa un bene comune. Se a mezzogiorno di un giorno di sole io produco più energia di quanta me ne serva, quell’energia verrà captata dai fili della bassa tensione e la userà il primo utente nelle vicinanze che schiaccerà un interruttore, probabilmente un mio vicino. La userà anche se non vuole, anche se non voglio.
Allo stesso modo l’elettricità prodotta in eccesso da una grande azienda finirà sui fili della media tensione e arriverà a un’altra fabbrica o si trasformerà in bassa tensione e raggiungerà casa nostra. Addirittura, se l’energia in eccesso è molta, avviene un’inversione del flusso: l’energia dalla bassa tensione torna indietro, alla media tensione. E così anche noi singoli cittadini possiamo in piccola parte alimentare una fabbrica. Insomma: di fatto siamo già una comunità energetica. Tanto che per il chimico industriale Leonardo Setti, se le cose funzionassero come dovrebbero non avremmo nemmeno bisogno di creare comunità energetiche come soggetti terzi: ognuna delle 450mila cabine secondarie sparse per tutto il Paese dovrebbe fungere da comunità energetica di fatto.
Il problema è che il mercato elettrico è ancora pensato per quei cinque o sei grandi produttori che irroravano energia in tutto il Paese. Ed ecco allora cosa succede: io produco energia in eccesso e il mio vicino la usa. Potrei decidere di fargliela pagare dieci centesimi ma anche di dargliela gratis. Invece devo per forza venderla alla rete centrale, magari sempre a dieci centesimi, e questa la rivende al mio vicino, magari questa volta a venti centesimi. Gliela vende a un prezzo maggiore per guadagnarci di più e perché l’energia fossile di cui si nutre maggiormente la rete centrale costa di più. Andrebbero scorporate, se ne sta parlando e già sarebbe un passo avanti. Al momento però l’energia solare di ogni cittadino e di ogni azienda viene gestita come fosse prodotta da quei grandi cinque o sei produttori. Stiamo facendo guadagnare un soggetto terzo con qualcosa che non è suo: l’energia è qualcosa quando esiste ed, entrando in circolo, diventa di tutti. Una volta prodotta diventa un bene comune, come l’aria o l’acqua di un fiume.
E qui arriviamo al punto. Se il mercato funzionasse come funzionano le rinnovabili, e in particolare il fotovoltaico, sarebbe del tutto orizzontale. Le bollette sarebbero molto basse lì dove ci sono più rinnovabili e a tutti converrebbe avere un pannello sul tetto. Il costo dell’energia rinnovabile è basso perché non è importata: è il vento o il sole della Sardegna e persino il sole di Milano. Non un gas estratto negli Stati Uniti o in Algeria, che deve attraversare oceani e mari. Dovremmo pagare in bolletta solo la manutenzione di quei preziosi fili che la trasportano in tutto il Paese, e dare la propria parte alle compagnie che avranno costruito magari i parchi eolici.
Non solo. Finora se si produce energia in un posto, per esempio in Sardegna, chi accetta quel parco eolico o quel rigassificatore ne trae un gran beneficio. Se il mercato funzionasse come funzionano le rinnovabili, i sardi che prenderanno energia dalla cabina secondaria vicina a un parco eolico avrebbero bollette molto più basse. Ci stiamo avvicinando, perché dal 2025 l’Italia è stata divisa in sette zone di prezzo, ma siamo ancora molto lontani dalle 450mila cabine-comunità energetiche di cui parla Setti. Inoltre, se il mercato assomigliasse alle rinnovabili si tutelerebbero tutti i kilowatt in eccesso prodotti da case e aziende, in modo che ognuno possa prenderne al bisogno, senza che nessun altro ci guadagni. Non sarebbe più lo strumento di guadagno di qualcuno, ma un bene comune. Diffuso, condiviso, di cui ognuno è un po’ responsabile e in cui ognuno può essere un po’ coinvolto.
Ora pensiamo a come funziona una centrale nucleare. Necessita di competenze iper-specifiche, da cui sono esclusi tutti coloro che non le hanno. Inoltre di per sé una centrale è un vulnus. Deve essere difesa e controllata costantemente, va protetta da eventi estremi, disattenzioni, anche attentati. Recentemente si è parlato della possibilità di mettere micro reattori nucleari direttamente all’interno delle imprese, in modo che si alimentino da soli. Se una grande centrale è sotto la responsabilità dello Stato e di un grande produttore, in questo caso sarebbero invece i privati, i singoli industriali, a decidere quanto spendere per la protezione del micro-reattore nella loro fabbrica. Sempre gli industriali dovrebbero procurarsi camion ultra protetti per il trasporto delle scorie. Ci sarebbero camion di scorie nucleari in giro per tutto il Paese, in direzione di centri di smaltimento, anch’essi ultra controllati e militarizzati. Un mondo completamente diverso da quello sicuro e condiviso di cui parlavamo poco fa.
In questo momento di transizione, il sistema da cui veniamo, fondato sull’energia fossile delle centrali termoelettriche, sta necessariamente, seppur molto lentamente, declinando. Abbiamo la fortuna di vivere in un momento storico in cui possiamo scegliere in che sistema energetico vogliamo vivere, e come abbiamo detto prima, in questo modo scegliamo anche il tipo di mondo che vogliamo costruire. Niente è neutrale. In ogni più piccolo gesto, scelta, ma soprattutto in ogni sistema alimentare, energetico, produttivo, si leggono una visione e una cura del mondo.
Come si ripete spesso, le rinnovabili costano poco e sono disponibili subito, mentre per costruire una nuova centrale ci vogliono burocrazia, controlli, tempo, e di tempo non ne abbiamo. Ma c’è anche un altro aspetto: se abbiamo il lusso di poter scegliere, è importante ricordarci che il significato della nostra scelta è più ampio di quel che pensiamo. Quando immaginiamo che tipo di sistema energetico vogliamo, immaginiamo anche una certa gestione della cosa pubblica. C’è il sistema centralizzato e militarizzato delle centrali nucleari: competenze di pochi, gestione statale e di potenti privati, polizia o militari a controllare ventiquattr'ore su ventiquattro. Di cosa avviene là dentro, dentro la centrale, chiunque di noi non sia un ingegnere non può avere alcuna contezza. Ne siamo in balia e allo stesso tempo ne siamo esclusi. È un’energia così delicata che anche giustamente non può essere democratica.
E poi ci sono le rinnovabili, un mondo orizzontale in cui ognuno può entrare, capire, avere voce in capitolo, produrre, prendere, condividere. Niente militarizzazione, per il pannello sul tetto o il piccolo parco eolico. Il controllo e la cura degli impianti è in mano allo Stato insieme ai cittadini, o almeno a tutti i cittadini che lo desiderano. È un sistema democratico in cui il bene comune viene prima del guadagno.
Se poteste scegliere, cosa scegliereste?
Caterina Orsenigo è scrittrice e giornalista. È laureata in filosofia a Milano e in letterature comparate a Parigi. Scrive di immaginari e crisi climatica per diversi giornali e riviste. Con Prospero Editore ha pubblicato il romanzo di viaggio “Con tutti i mezzi necessari”. Organizza passeggiate letterarie con l’associazione Piedipagina e fa parte del comitato organizzativo del corso di perfezionamento in Ecosocialismo dell’Università Bicocca.
Il podcast di A Fuoco
Eventi climatici estremi, l’inesorabile riduzione delle nevicate e l’alterazione degli equilibri naturali che una volta conoscevamo: la crisi climatica sta modellando il nostro futuro, eppure sembra ancora troppo difficile affrontarla con la necessaria urgenza. Come possiamo reagire a questa trasformazione che minaccia non solo l’ambiente, ma anche le economie locali, in particolare quelle delle montagne, sempre più vulnerabili?
Nella dodicesima puntata del podcast di A Fuoco, Sofia Farina, fisica dell’atmosfera e comunicatrice scientifica, ci aiuta a fare luce sui cambiamenti che stanno modificando per sempre le nostre Alpi e gli Appennini, mettendo in evidenza gli effetti devastanti del riscaldamento globale e come possiamo ancora intervenire per ripensare l’economia montana.
Potrete trovare questo e tutti gli altri episodi del podcast di A Fuoco su Spotify e sulle tradizionali piattaforme dove si ascoltano i podcast. Buon ascolto!
Memini climatici






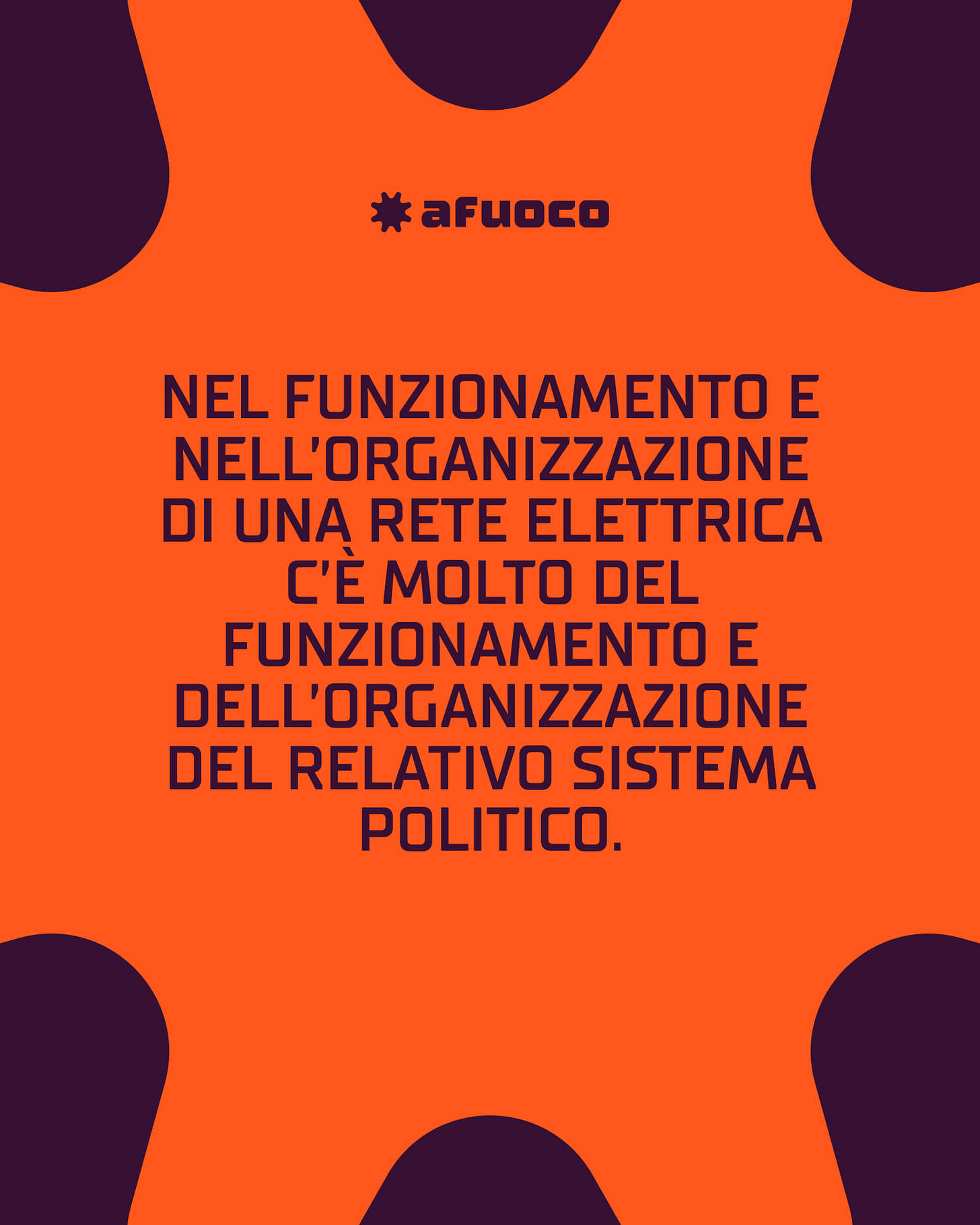

La sua analisi è totalmente avulsa dalla realtà fisica di come funziona il sistema elettrico. Non si può immettere nella rete senza passare dal gestore altrimenti la rete si sbilancia e avvengono i black out. La prima domanda da farsi comunque é se le rinnovabili sono in grado di soddisfare il fabbisogno energetico nazionale. La risposta è no e soprattutto no con i pannelli sul tetto delle case. Già da questo la sua discussione perde di forza. Seconda cosa l’energia data dai pannelli non é totalmente gratis dal punto di vista ambientale; l’energia nucleare è molto più pulita. Terza cosa gli SMR cioè i piccoli reattori per le aziende saranno probabilmente di quarta generazione e produrranno un quantitativo di scorie irrisorio. Altro che camion che girano per I paese. Le scorie rimangono nel reattore, e a fine vita, dopo 50 anni, si smaltisce il tutto. Come al solito chi parla di questi argomenti non ha preparazione tecnica e si vede. Si mistifica la realtà e in sostanza si fa propaganda green invece che vera informazione. Le ricordo che l’ecologia é produrre energia senza distruggere il pianeta; tutte le altre considerazioni new age e filosofiche vanno lasciate fuori altrimenti lo scopo e la battaglia ne viene attenuata. Come al solito in Italia parla chi non ha titoli e chi è chiaramente di parte.
Il modo in cui viene raccontata l’energia nucleare è (volutamente) caricaturale. Parlare di centrali come luoghi militarizzati, pericolosi e inaccessibili, contrapposti a un mondo ideale di pannelli solari condivisi, semplifica una realtà che è molto più complessa. Il nucleare ha senz’altro bisogno di competenze specifiche e controlli severi, ma lo stesso vale per tantissime altre infrastrutture energetiche. E mentre si insiste molto sui rischi teorici, non si considera che ogni anno l’inquinamento da fonti fossili causa danni enormi, anche in termini di vite umane. Le rinnovabili sono indispensabili, su questo siamo tutti d’accordo, ma oggi da sole non bastano: sono intermittenti, richiedono risorse non sempre facilmente disponibili e hanno bisogno di sistemi di accumulo ancora costosi. In questo contesto, escludere il nucleare a priori rischia di rallentare la transizione. Un sistema energetico davvero equo e sostenibile deve basarsi su un mix di soluzioni, senza ideologie. Valutare tutte le opzioni disponibili – compreso il nucleare di nuova generazione – è un atto di responsabilità, non una rinuncia alla democrazia