I dissalatori sono la soluzione alla siccità?
di Francesca Polizzi
Era il 25 marzo scorso – da qualche giorno era iniziata la primavera – quando Nicola Dell’Acqua, commissario straordinario nazionale per l’emergenza idrica, dichiarava: «Ho una visione pessimistica, il Meridione e le isole hanno per i bacini una situazione peggiore dell’anno scorso, la prossima estate sarà particolarmente dura».
Secondo l’ultimo aggiornamento dell’osservatorio dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) sullo stato di severità idrica in Italia – datato 15 maggio 2025 – il distretto idrografico della Sicilia risulta con severità idrica “alta”. Ma questa situazione non è una novità: da mesi si ragiona sulle strategie per contrastare la siccità.
Tra le decisioni prese c’è lo stanziamento di 20 milioni di euro per la fase di avvio degli impianti di dissalazione (detti anche dissalatori o desalinizzatori), mentre altri 90 milioni sono stati inseriti nell’accordo di coesione per un piano idrico più ampio. L’accordo raggiunto tra la regione Sicilia e il governo prevede la riattivazione dei tre dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle, dismessi da più di dieci anni. A questi si aggiungerà la costruzione di un nuovo dissalatore a Porto Empedocle. Dalle ultime dichiarazioni di Renato Schifani, presidente della regione siciliana, sembra che «entro luglio questi tre dissalatori [Gela, Trapani e Porto Empedocle, ndr] saranno in funzione».
Gli impianti di dissalazione sono strutture in grado di trasformare l’acqua salata – in questo caso marina – in acqua potabile. Una mossa che punta a tamponare una crisi idrica sempre più grave, con laghi e fiumi ridotti ai minimi storici, gravi danni per l’agricoltura e l’allevamento e continui razionamenti nelle forniture idriche in molti paesi e città dell’isola.
Una svolta infrastrutturale, certo. Ma i dissalatori sono davvero la soluzione più efficace e sostenibile per affrontare il problema strutturale della siccità?
Un impianto di dissalazione rimuove il sale dall’acqua di mare, rendendola potabile. I due metodi più diffusi sono l’osmosi inversa e la distillazione. Il primo, più comune, prevede l’utilizzo di una pressione idraulica che spinge l’acqua salata attraverso una membrana, in questo modo l’acqua viene filtrata. Il secondo metodo sfrutta l’evaporazione dell’acqua marina per separarla dal sale. «Con l’acqua di mare, ad esempio, riusciamo a estrarre tra il 40 e il 60 per cento al massimo di acqua dolce», dice Alberto Tagliaferri, docente del Politecnico di Torino e parte del team del Clean Water Center dello stesso Politecnico.
Quello che resta dopo il processo di desalinizzazione è un concentrato di acqua ipersalinizzata detta anche “salamoia”. Questo residuo andrebbe considerato e trattato come un rifiuto speciale. Data la vicinanza dei dissalatori al mare, la soluzione più semplice, veloce ed economica è riversare la salamoia in mare, solitamente in un unico punto. «Il modo in cui viene fatto questo passaggio determina poi l’impatto sugli ecosistemi», spiega Tiraferri. A livello ingegneristico le alternative esistono: «la si può immettere, ad esempio, al largo e cercando di diffonderla il più possibile. In questo processo si usano i cosiddetti diffusori che fanno sì che non si crei un ambiente locale ad alta salinità».
Ad acuire il problema dello smaltimento della salamoia subentra anche la mancanza di una legislazione specifica. Attualmente la salamoia viene paragonata alle acque reflue industriali, e di conseguenza gestita allo stesso modo. «In realtà questa legislazione non è adatta per questa nuova applicazione, quindi bisognerebbe rivederla», spiega Tiraferri. Poi aggiunge: «Sarebbe opportuno che ci fosse una legislazione chiara che faccia capire a chi vuole installare un nuovo impianto quali sono i vincoli da rispettare».
I dissalatori rappresentano una tecnologia utile ma non priva di costi ambientali ed energetici. Quello del consumo energetico elevato è un nodo cruciale. Come spiega Tiraferri: «L’energia che serve ad oggi per prendere acqua salata dal mare, fare tutti i trattamenti che servono – tra cui la dissalazione e poi scaricare la salamoia di nuovo in mare – va tra 4 e 10 chilowattora (kWh) per metro cubo di acqua che produciamo [range ampio che dipende dalla grandezza dell’impianto, ndr]. Per trattare acqua di fiume o di lago – che è quella che si utilizza principalmente oggi per fare acqua potabile – si usa un decimo o meno di questa energia».
A preoccupare è anche la «mancanza di studi approfonditi sull’impatto ambientale a lungo termine», chiarisce Tiraferri. Al di là di questo, però sostiene che «gli impianti, se fatti in modo ingegneristicamente appropriato, hanno impatti bassi».
Nei territori coinvolti, l’annuncio del ritorno dei dissalatori è stato accolto con sentimenti contrastanti. Da una parte c’è chi spera che questi impianti possano finalmente garantire un approvvigionamento idrico stabile. Dall’altra, i comitati locali e il Forum siciliano dei movimenti per l’acqua e i beni comuni segnalano preoccupazioni ambientali e chiedono che i progetti siano accompagnati da valutazioni di impatto trasparenti e da un confronto con le comunità locali. Lo racconta Antonella Leto del Forum siciliano dei movimenti per l’acqua e i beni comuni: «I dissalatori sono super energivori, per cui l’acqua dissalata costerebbe molto denaro in più rispetto all’acqua che si potrebbe accumulare in maniera corretta se avessimo un sistema idrico efficiente».
Riguardo alla dissalazione Leto aggiunge un’altra nota negativa: «l’attivazione di impianti di dissalazione si propone come elemento che va a minare una gestione interamente pubblica». A tal proposito, Leto fa riferimento al progetto di costruzione di due dissalatori a Palermo. «La regione prevede di farli in project financing e secondo noi l’obiettivo è quello di arrivare a privatizzare l’acqua per la provincia di Palermo». Pattern ricorrente è l’assenza di coinvolgimento delle comunità locali: la Convenzione di Aarhus – che riguarda l’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e la giustizia ambientale – è sistematicamente disattesa.
«Manca la consapevolezza sui rischi, anzi, al contrario i dissalatori sono accolti con grande favore dalle persone», continua Leto. Poi aggiunge: «Quando l’acqua non esce dai rubinetti, soprattutto se sei in una zona balneare e hai bisogno non solo di lavarti, di mangiare o di bere, ma anche di fare funzionare il bar, il ristorante, il B&B e non hai acqua, qualsiasi acqua va bene, quindi è chiaro che le persone poi tendono a vedere i dissalatori come un elemento positivo». Secondo Leto i dissalatori possono essere una soluzione emergenziale da considerare come ultima spiaggia tra le strategie possibili per risolvere la crisi idrica siciliana. Bisogna immaginare soluzioni a lungo termine che permettano di ripensare l’intero sistema idrico regionale, puntando su manutenzione delle reti, riparazione delle dighe e di tutte le infrastrutture, riuso delle acque reflue e una vera gestione pubblica e sostenibile della risorsa idrica.
Nel quadro delle politiche europee, la dissalazione è considerata una tecnologia complementare, da usare in modo mirato nei territori soggetti a stress idrico, come le regioni mediterranee. In particolare, la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) invita gli Stati membri a promuovere un uso sostenibile delle risorse idriche, privilegiando il risparmio, il riuso e la gestione integrata del ciclo dell’acqua.
I dissalatori possono essere parte della soluzione, ma non possono sostituirsi a politiche strutturali di tutela e gestione dell’acqua. In Sicilia, dove le perdite della rete idrica superano il 50 per cento, l’efficienza del sistema resta il nodo centrale. Senza investimenti strutturati, ogni intervento rischia di trasformarsi in una toppa temporanea su un problema sistemico.
Francesca Polizzi è una giornalista freelance. Si occupa di questioni di genere, crisi climatica e più in generale di temi sociali. Collabora con testate nazionali e internazionali. Ha frequentato la scuola di giornalismo Lelio Basso e ha conseguito il master in Studi e Politiche di Genere.
Memini climatici
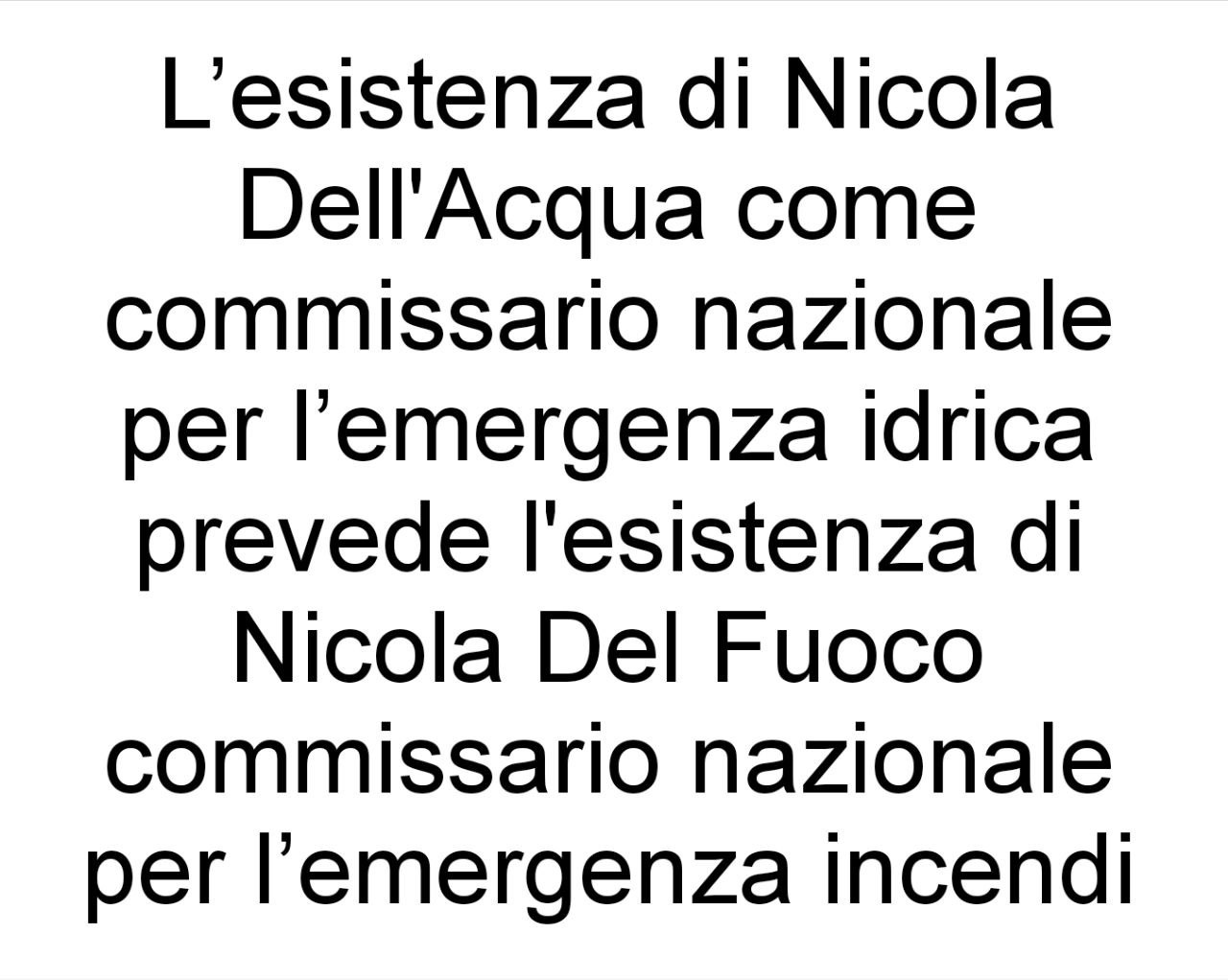







C'è anche un altro punto da considerare : nel sud Italia, le reti idriche perdono metà dell'acqua che viene immessa. Dissaliamo a caro prezzo per disperdere l'acqua?
E ovviamente se le perdite fossero ridotte, se ancora necessari, gli impianti di dissalazione potrebbero essere più piccoli.