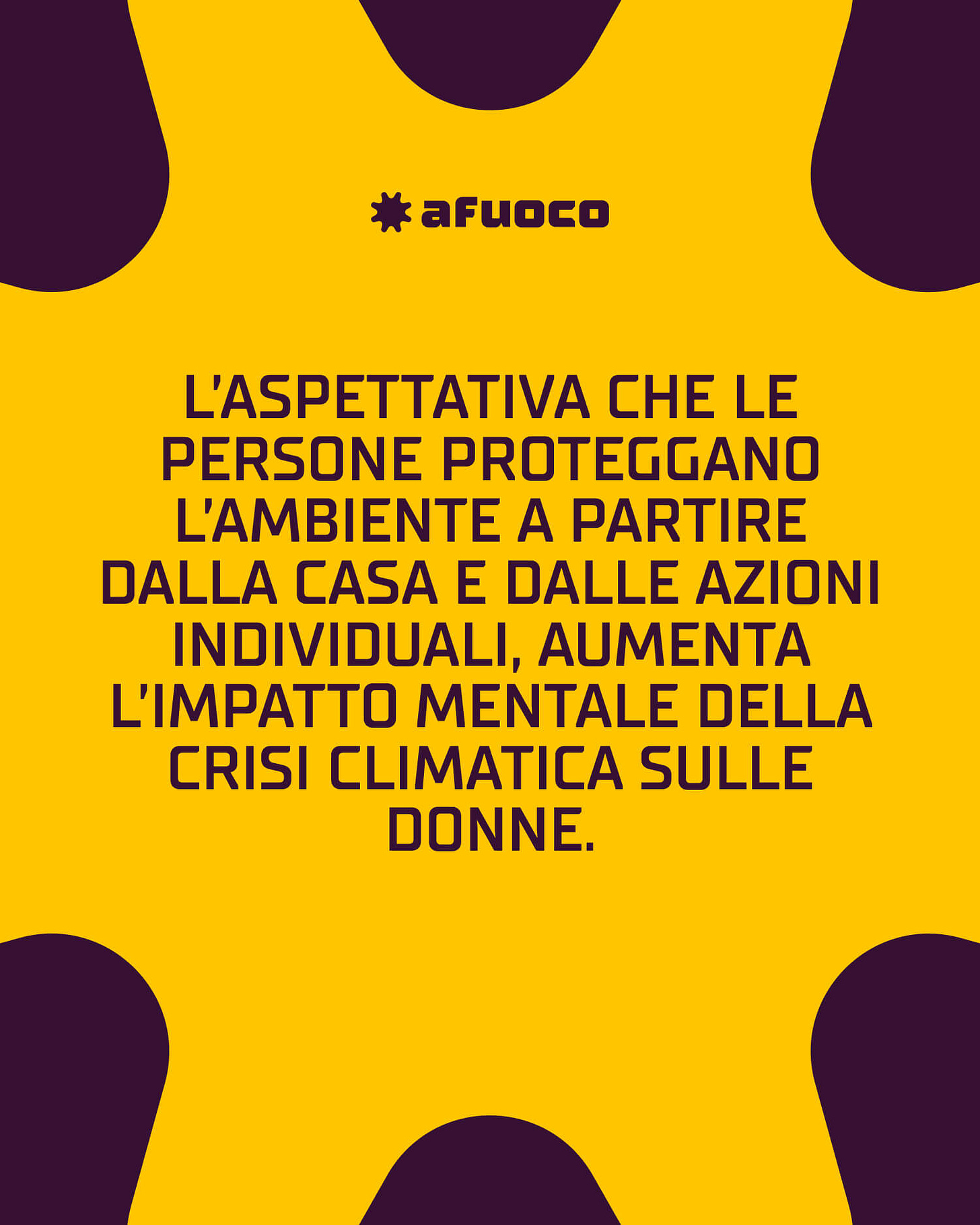Salvare il pianeta è un lavoro per donne?
di Chiara Comerci
Diversi studi in tutto il mondo mostrano che quello femminile è il genere con livelli maggiori di eco-ansia, definita dall’American Psychological Association come la «paura cronica del disastro ambientale». Questa risposta emotiva adattiva e coerente è in costante aumento tra i giovani occidentali, con sintomi che possono comprendere ansia, senso di colpa, attacchi di panico e depressione. I principali fattori di rischio sono l’età giovane, l’essere a contatto con la natura e l’appartenenza al genere femminile. Tuttavia, mentre esiste un elevato numero di ricerche che indagano la relazione tra l’eco-ansia e i primi due fattori, sono pochissimi gli studi che cercano di comprenderne il legame con il genere.
Alcune narrazioni suggeriscono una differenza biologica: le donne sono più inclini per natura alla cura e alla preoccupazione, e quindi più sensibili alla crisi climatica. Altre ipotesi suggeriscono che sia per la loro vulnerabilità ai disastri naturali, o per la maggiore consapevolezza delle pratiche sostenibili della vita quotidiana, essendo le principali responsabili della gestione domestica.
L’associazione tra donne e natura ha radici storiche profonde, con la Terra rappresentata spesso come una figura materna, la Madre Terra, e divinità femminili legate alla fertilità. Il movimento eco-femminista si basa proprio su questa connessione, evidenziando la correlazione tra l’oppressione di genere e lo sfruttamento naturale, sostenendo che l’esperienza storica di oppressione rende le donne inclini a difendere l’ambiente. In effetti, le donne hanno da sempre avuto un ruolo chiave all’interno dell’attivismo climatico, guidando movimenti ecologisti globali.
Le donne non solo sperimentano maggiore eco-ansia, ma tendono anche a adottare più frequentemente comportamenti pro-ambientali, definiti come il «tentativo consapevole di ridurre l’impatto negativo delle proprie azioni sul mondo naturale e costruito». Chi è preoccupato per l’ambiente è difatti spinto ad agire per proteggerlo, sia per una maggiore consapevolezza degli effetti delle proprie azioni, sia per il senso di colpa che spesso accompagna l’eco-ansia.
Questa differenza di genere nei comportamenti pro-ambientali è definita “eco gender gap”, ed è un fenomeno confermato in diverse nazioni, tra cui Australia, Canada, Svezia, Stati Uniti e Italia. Tuttavia, molte ricerche si limitano a registrare questa differenza senza approfondirne le cause, o attribuendole al maggiore tempo libero delle donne per occuparsi della casa e dell’ambiente.
Ma se questo maggiore impegno riflettesse il carico sproporzionato delle donne nei lavori domestici?
Una ricerca del 2018 evidenzia che la scala utilizzata per misurare i comportamenti pro-ambientali include principalmente attività legate all’ambiente domestico (come riciclare o ridurre i consumi elettronici), in cui le donne sono più coinvolte. Lo studio dimostra anche che, quando uomini e donne in un nucleo familiare lavorano lo stesso numero di ore, il divario nei comportamenti sostenibili permane, con le donne che si occupano della gestione domestica e delle scelte più legate alla sostenibilità. Molti studi infatti giustificano questo divario nel lavoro domestico con l’argomento della specializzazione: in una coppia chi ha più tempo libero si occupa dei lavori domestici e delle scelte quotidiane. Ma i risultati di questa ricerca dimostrano che il lavoro domestico non è una questione di efficienza, ma di aspettative sociali e culturali: le donne vengono ancora percepite come le principali responsabili della cura della casa e della famiglia, e questo influenza il loro ruolo nelle scelte ecologiche.
È probabile che la disuguaglianza nei comportamenti sostenibili sia simile ad altri tipi di lavori domestici, riflettendo (e potenzialmente rafforzando) disuguaglianze di genere più ampie nella società. Nel dibattito ambientale femminista si è parlato di «femminilizzazione della responsabilità ambientale», per indicare che, se le donne sono percepite come responsabili del lavoro domestico, anche a parità di ore lavorative del partner, questo aggrava il loro compito di cura. In presenza di una già iniqua divisione del carico di lavoro domestico, gli inviti ad essere più “green” potrebbero aumentare il senso di colpa delle donne. Il marketing etico e sostenibile seguirebbe questo trend, rivolgendosi maggiormente ad un pubblico femminile.
Secondo la teoria dei ruoli di genere, gli stereotipi associati al genere femminile includono l’essere subordinate, comunitarie e inclini alla cura. Ci si potrebbe quindi aspettare che le donne si impegnino maggiormente nella cura della casa e dell’ambiente come risultato di una narrazione sociale che associa l’ecologia alla femminilità e il consumo sfrenato e industrie inquinanti (come quella della carne e dei motori) alla mascolinità. Se a questo aggiungiamo l’aspettativa che le persone proteggano l’ambiente a partire dalla casa e dalle azioni individuali, l’impatto mentale della crisi climatica sulle donne aumenta: è il loro terreno “tradizionale” che viene elevato ad apice del comportamento ambientale. Questo maggiore impegno, combinato con le aspettative della società, può portare a un aumento dell’eco-ansia e della preoccupazione ambientale. Se l’ambientalismo verrà sempre più visto come un comportamento domestico, allora saranno le vite delle donne a essere messe sotto la lente d’ingrandimento, man mano che questa nuova morale ecologica individualista si farà strada.
Viene quindi da chiedersi se l’eco-ansia che sperimentano sia legata all’aspettativa implicita che, a seguito di un disastro ambientale, dovrebbero essere loro a portarne il carico emotivo, essendo spesso le responsabili della famiglia e del lavoro domestico. Un articolo del 2017 ipotizza che gli uomini potrebbero sentirsi meno vulnerabili ai disastri ambientali in quanto gruppo, e quindi più “immuni”. Le donne sono infatti la categoria più esposta alla crisi climatica, con una maggiore diagnosi di disturbo post traumatico da stress e depressione a seguito di un disastro. Le donne rappresentano anche il 70 per cento delle persone in povertà, condizione che peggiora di fronte a disastri climatici perché, quando l’accesso all’acqua e al cibo è compromesso, il loro carico di lavoro (domestico e non) aumenta. Senza contare le innumerevoli ricerche che dimostrano come l’innalzamento delle temperature sia legato ad un aumento della violenza di genere.
Questa differenza nei ruoli di genere potrebbe spiegare il modo in cui donne e uomini vivono la crisi climatica in maniera differente: le donne sono più esposte non solo agli eventi atmosferici estremi, ma anche all’eco-ansia perché la società le considera come il genere empatico e le assegna un ruolo di cura e di responsabilità verso la propria famiglia, anche durante i disastri ambientali. In sostanza, le differenze nella salute mentale legata al cambiamento climatico esistono perché le disuguaglianze di genere esistono, e i piani di gestione dei disastri devono affrontare queste tematiche, rafforzando la resilienza comunitaria, e prendendo in considerazione il ruolo di responsabilità familiare delle donne come ulteriore fattore di stress.
L’eco-ansia è quindi influenzata dalla classe, dal genere e dal privilegio, perché la crisi climatica non sta colpendo tutte le persone allo stesso modo, ma esacerbando disuguaglianze già esistenti, tra cui quella di genere. La speranza è che la ricerca futura esplori più a fondo l’impatto dei ruoli di genere sull’eco-ansia e sulle aspettative di cura verso l’ambiente. Ma la principale aspettativa è quella di superare il binarismo di genere, rendendo il ruolo di cura non più una responsabilità delle persone socializzate donne, ma un carico realmente collettivo. Solo una rivoluzione socio-ecologica può garantire che la crisi climatica non pratichi più la discriminazione di genere.
Chiara Comerci è dottoressa in Psicologia Clinica, si occupa di ricerca sull’eco-ansia e sulla preoccupazione ambientale, divulgazione scientifica e redazione di articoli. È attivista e lavora con l’associazione Open Gates di Padova, che offre supporto legale e psicologico a persone migranti e senza fissa dimora. Nell’ambito dell’associazione, è responsabile del progetto “Armadio Popolare,” dedicato al riuso di materiale tessile a scopo sociale. I suoi interessi comprendono questioni ambientali, sociali e di genere con una prospettiva eco-femminista.
Il podcast di A Fuoco
Eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, temperature record e catastrofi naturali che si susseguono senza sosta: la crisi climatica sta ridisegnando il nostro presente, ma rischia anche di trasformarsi in una nuova, inquietante normalità. Come possiamo evitare di assuefarci a questa emergenza continua? E cosa ci dicono davvero questi segnali sull’accelerazione del riscaldamento globale?
Questa è l’undicesima puntata del podcast di A Fuoco, scritto e condotto da Anna Toniolo, prodotto da Jessica Mariana Masucci. Nell’episodio di oggi chiacchiereremo con Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso l’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBE-CNR) e il Consorzio LaMMA.
Potrete trovare questo e tutti gli altri episodi del podcast di A Fuoco su Spotify e sulle tradizionali piattaforme dove si ascoltano i podcast. Buon ascolto!
Memini climatici