Il rischio di abituarsi a una realtà “estremamente normale”
di Giulio Betti
In un’epoca in cui informare significa spesso travolgere le persone con valanghe di contenuti usa e getta, può succedere che un’eccezionale sequenza di fenomeni meteorologici estremi venga rapidamente dimenticata o, nel migliore dei casi, vissuta come normale.
Negli ultimi tre anni, ed in particolare nel 2023 e nel 2024, il mondo ha registrato un numero impressionante di eventi estremi, molti dei quali hanno colpito l’Europa e l’Italia. Nel 2022 gran parte del vecchio continente ha fatto i conti con la più intensa siccità degli ultimi 500 anni, poi nel 2023, oltre al caldo, sono arrivate perturbazioni rabbiose. A maggio la doppia alluvione che ha sconvolto l’Emilia-Romagna, a seguire un’estate contraddistinta da grandinate eccezionali al Nord (chicco di 19 cm di diametro caduto in Friuli), da inondazioni sulla regione alpina e da forti ondate di calore al centro-sud, dove si sono registrati numerosi record termici (48.2 °C in Sardegna, 45 °C in Basilicata, 47 °C a Palermo). Al di fuori dell’Europa l’uragano Otis, contro ogni previsione, è passato in brevissimo tempo a categoria 5 devastando la città di Acapulco e provocando danni per 14 miliardi di dollari.
Tutto questo avveniva mentre le curve termiche dell’atmosfera e dei mari del pianeta puntavano verso valori mai osservati prima; quasi otto miliardi di persone sono state protagoniste, per lo più inconsapevoli, di una drammatica accelerazione del riscaldamento globale. La temperatura media della Terra, nel 2023, è risultata 1.48 °C al di sopra del periodo preindustriale (Copernicus), quindi a un passo dal limite fissato di 1.5 °C dagli ormai illusori obiettivi della Cop di Parigi del 2015. Nel settembre del 2023, due disastrose alluvioni hanno colpito la Tessaglia (Grecia) e la Libia causando danni incalcolabili e, nel caso dello stato nordafricano, migliaia di morti; si è trattato, a livello globale, della peggior sciagura climatica in termini di vittime di tutto l’anno. I due eventi non sono stati causati da abbondanti piogge cadute in più giorni, ma da precipitazioni violentissime concentrate in poche ore.
Passano le settimane, ma gli eventi estremi no; dopo un ottobre eccezionalmente caldo, nel mese di novembre un’alluvione lampo mette in ginocchio parte della Toscana. Il 2023 si chiuderà, negli USA, con 4 episodi alluvionali maggiori e per il Canada risulterà l’anno con la maggior superficie di territorio percorsa da incendi (circa 6 milioni di ettari in soli tre mesi). Intanto il calendario concede il sipario al 2024. Anche l’anno in questione mostra il lato più estremo del clima; mentre l’anomalia termica globale ereditata dal 2023 non accenna a ridursi, il Brasile meridionale viene colpito dalla peggiore alluvione degli ultimi 80 anni.
L’Africa centro-occidentale, e in particolare il Sahel, sono sconvolte da piogge senza precedenti, che costringono 6.6 milioni di persone ad abbandonare le proprie case e i propri villaggi; l’Emilia-Romagna, tra settembre e ottobre, registra due nuove alluvioni lampo (quattro in un anno e mezzo) e l’Europa centro-orientale viene attraversata dal vortice Boris che provoca inondazioni in Austria, Slovacchia, Polonia e Romania.
Nel frattempo, tre uragani maggiori colpiscono il Golfo del Messico e parte degli Stati Uniti meridionali: Beryl, Helene e Milton. Il primo è risultato l’uragano categoria 5 più precoce mai registrato in Atlantico (28 giugno) e il più intenso mai sviluppatosi nel mese di luglio, il secondo è stato il più distruttivo per la Florida nordoccidentale e il più letale per gli Stati Uniti continentali dopo Katrina (2005), infine il terzo è stato il sistema che si è intensificato più rapidamente da depressione tropicale a uragano categoria 5 (in sole 49 ore). Il 2023 e il 2024 hanno “unito le forze” restituendoci una riduzione record dei ghiacciai alpini (-12 per cento del volume) e il più esteso evento di sbiancamento dei coralli mai documentato.
Quanti di questi eventi estremi ricordate o conoscevate? Forse alcuni, sicuramente non tutti, perché sono stati moltissimi e soprattutto rappresentano soltanto una piccola, ma significativa, parte del totale. Una persona che non si occupa di meteorologia o climatologia affermerebbe che sono “tanti”, un esperto affermerebbe che sono “troppi”. Siamo, infatti, oltre l’anomalia; quello che abbiamo osservato e misurato negli ultimi due anni è qualcosa di sconosciuto o, come affermano molti scienziati, qualcosa che appartiene ad un “territorio inesplorato”. I fenomeni meteorologici estremi ci sono sempre stati, anche prima del rapidissimo e innaturale aumento avvenuto negli ultimi 40-50 anni; la fondamentale differenza col passato è che gli eventi che registriamo oggi sono più frequenti e intensi a causa del surplus di calore e vapore acqueo contenuto in atmosfera.
Se in appena quarant’anni le ondate di calore terrestri e marine sono più che raddoppiate e le fasi siccitose sono diventate più durature, i nubifragi e le alluvioni mostrano un andamento più irregolare. In alcune aree del pianeta, infatti, evidenziano trend in crescita, in altre no; tuttavia, laddove non aumentano in numero, la probabilità che le alluvioni risultino più intense del passato è sempre maggiore. È il caso delle piogge eccezionali cadute il 29 ottobre 2024 su parte della comunità valenciana, sconvolta da una delle più disastrose inondazioni della storia della Spagna. In poche ore sulla regione si sono registrati cumulati superiori a quelli che normalmente cadono in un anno (fino a 179 mm in un’ora, 470 mm in 3 ore e mezzo e circa 800 mm in 24 ore). Una tragedia avvenuta nel Mediterraneo, non lontano dall’Italia, la stessa Italia che pochi giorni prima del disastro registrava forti criticità idrogeologiche in Liguria e su parte del Nord Ovest.
La domanda che dobbiamo porci a questo punto è: tra quanto tempo il prossimo evento estremo ci farà dimenticare i precedenti? Quanti contenuti chiassosi e superficiali ci distrarranno dal problema? Nessuno è al sicuro dagli effetti del cambiamento climatico, neppure chi questi effetti tende a dimenticarli in fretta.
L’incredibile accelerazione del riscaldamento del pianeta avvenuta negli ultimi due anni ci sta davvero traghettando verso una nuova fase climatica? Probabilmente sì (e non è un bene), ma la prova definitiva ce la deve fornire la scienza confermando o meno il raggiungimento di un tipping point. Qualcuno ne avrà sentito sicuramente parlare; il tipping point è, in termini semplici, un cambiamento irreversibile di un sistema (nel nostro caso climatico e ambientale) causato da una forzante esterna (l’aumento delle temperature globali). Un sistema che subisce stress continuativi ed eccessivi, come ad esempio la foresta Amazzonica o i ghiacciai antartici Pine Island e Thwaites, a un certo punto cede e subisce cambiamenti radicali. Tali cambiamenti spesso non fanno altro che aggravare lo stato del sistema stesso con ripercussioni gravi anche a scala regionale e globale.
In altre parole, se davvero stiamo camminando su uno “scalino” climatico, dobbiamo aspettarci un’accelerazione dei processi già in atto quali: riduzione dei ghiacciai, aumento delle ondate di calore, innalzamento del livello dei mari, siccità più frequenti, alluvioni lampo e perdita di biodiversità. Lo so, non è uno scenario molto rassicurante, ma la realtà dei fatti ci impone di contemplarlo con estrema serietà anche perché non si tratta di una tendenza a 30-40 anni, ma di qualcosa che sta accadendo proprio adesso. Il possibile raggiungimento di un tipping point non deve scatenare il panico o, all’opposto, portare molti a nascondere la testa sotto la sabbia, bensì creare maggior consapevolezza al fine di accelerare veramente le politiche di abbattimento delle emissioni di gas serra e adattamento agli impatti del cambiamento climatico.
Dobbiamo fare in modo che la parola “normale” sia distinta dalla parola “estremo”, perché il giorno in cui riterremo di poter convivere con una estrema normalità, sarà il giorno in cui avremo gettato definitivamente la spugna.
Giulio Betti è meteorologo e climatologo presso l’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBE-CNR) e il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale). Attivo nel campo della meteorologia da oltre 20 anni, si occupa di previsioni a supporto alla catena di allertamento della Protezione Civile della Toscana, ricerca scientifica, reportistica meteo-climatica e divulgazione mediatica. Ha all'attivo numerosi articoli e interviste sia radio che TV. Nel 2022 è stato nominato “meteorologo dell’anno” dal UNI-MET.
Memini climatici






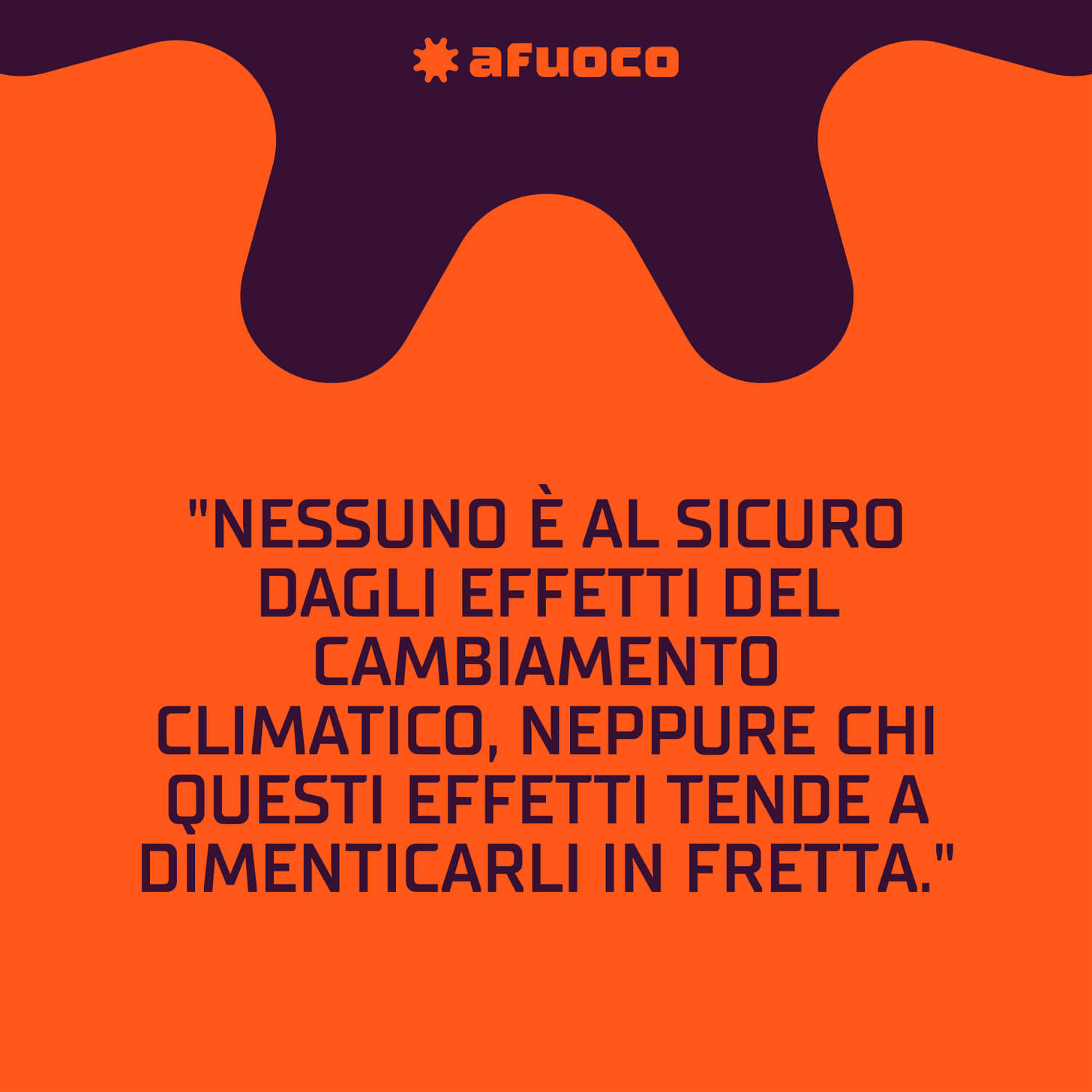

La cosa che mi fa più paura è vedere che chi dovrebbe fare qualcosa nel concreto, invece, nutre questa falsa retorica del maltempo, dice un paio di parole di cordoglio di circostanza all'occorrenza e il giorno dopo è tutto dimenticato, come se non dovesse sucedere di nuovo nel giro di qualche settimana. Non sento discutere di misure pratiche per fronteggiare quello che abbiamo causato.
Grazie per aver messo in fila tutti questi eventi, forse aiuterà a capire che la situazione normale non è.
Secondo George Lakoff, linguista e cognitivista autore di "Non pensare all'elefante", il termine "cambiamento climatico" è stato introdotto da Frank Luntz, guru del linguaggio del mondo dei conservatori statunitensi, affinché si smettesse di utilizzare il termine "riscaldamento globale", termine che riteneva suonare inquietante e implicare la responsabilità degli esseri umani.
Forse sarebbe opportuno iniziare ad utilizzare un diverso termine, scelto in base a considerazioni linguistiche e cognitivistiche, in modo da veicolare con immediatezza il concetto della responsabilità della specie umana nella alterazione del clima del pianeta